Con valutazioni azionarie storicamente alte e incertezze sulla politica monetaria della Federal Reserve, molti investitori temono un ritorno a uno scenario di rendimenti deludenti come negli anni Settanta. In quell’epoca, infatti, i mercati azionari vissero un decennio “perduto”, con performance stagnanti e fortemente erose dall’inflazione. Oggi alcune analogie preoccupano gli operatori: l’inflazione è risalita ai massimi da decenni, la banca centrale statunitense sta alzando i tassi bruscamente e le valutazioni di Borsa appaiono elevate. Ma la storia potrebbe non ripetersi allo stesso modo, grazie anche a nuove forze dirompenti come l’intelligenza artificiale (AI) e ad importanti differenze strutturali rispetto a cinquant’anni fa. In questo articolo analizziamo le prospettive dei mercati azionari alla luce di queste dinamiche, confrontando la situazione attuale con quella degli anni ’70 e valutando perché i prossimi anni potrebbero riservare sorprese positive nonostante i timori.
Valutazioni elevate e timori di rendimenti “anni ’70”
Una prima fonte di preoccupazione è data dalle valutazioni azionarie storicamente alte. Gli indici di Borsa, soprattutto negli Stati Uniti, trattano su multipli di utili ben superiori alle medie di lungo periodo. Ad esempio, il CAPE ratio (rapporto prezzo/utili aggiustato per il ciclo degli utili decennali) per l’S&P 500 si è attestato recentemente sopra quota 30-35, un livello raggiunto in passato solo alla vigilia di eventi eccezionali come il 1929 o la bolla tecnologica del 2000. In altri termini, il mercato americano è costoso rispetto ai fondamentali, e ciò storicamente ha spesso preannunciato rendimenti futuri modesti.
Quando gli investitori pagano molto per ogni dollaro di utili societari, è lecito attendersi che nei successivi anni la crescita delle quotazioni sia più lenta, finché gli utili non “raggiungono” i prezzi. Questo fenomeno si è già visto in passato: alla fine degli anni ’60, un periodo di forte espansione borsistica, i multipli azionari erano elevati e furono seguiti da un lungo decennio di risultati deludenti negli anni ’70. Allo stesso modo, dopo l’euforia della fine anni ’90 (con valutazioni stellari durante la bolla dot-com), i mercati hanno vissuto il decennio 2000-2009 con rendimenti pressoché nulli.
Inizia ad investire anche tu con Fineco
Apri un Conto Corrente Fineco, la banca più innovativa e affidabile d’Italia.
Pubblicità di affiliazione – se apri un conto tramite questo link, Economia Italiacom può ricevere una commissione, senza alcun costo per te.
Oggi ci troviamo in una situazione simile? La forte ascesa dei listini nell’ultimo decennio (anni 2010) ha portato l’S&P 500 e altri indici su livelli di prezzo molto sostenuti. Alcuni analisti prevedono che i prossimi 5-10 anni potrebbero offrire ritorni ben inferiori alla norma. Per esempio, una recente analisi di Goldman Sachs ha stimato che c’è circa il 72% di probabilità che l’S&P 500 underperformi i titoli di Stato decennali e un 33% di probabilità che le azioni ottengano addirittura rendimenti reali negativi (cioè sotto l’inflazione) nel corso del prossimo decennio. In termini concreti, questo scenario implicherebbe un rendimento annuo nominale intorno al 3% – un valore così basso che, storicamente, si è riscontrato solo in periodi difficili come la Grande Depressione degli anni ’30, la crisi degli anni ’70 o la crisi finanziaria del 2008.
Queste previsioni cupe alimentano il timore di un “ritorno al passato”, ovvero che i mercati azionari possano trovarsi in una fase prolungata di scarsa performance, proprio come accadde negli anni Settanta. Ma per capire quanto sia fondato questo parallelo, occorre rievocare cosa avvenne in quel decennio e perché.
Uno sguardo agli anni ’70: il decennio perduto della Borsa
Gli anni 1970 sono ricordati come un periodo molto difficile per gli investitori azionari, al punto da essere spesso definiti un “decennio perduto”. A differenza di crolli improvvisi come il 1929 o il 2008, i mercati negli anni ’70 vissero una lunga agonia fatta di andamenti laterali e discese graduali. Chi aveva investito in azioni alla metà degli anni ’60 si ritrovò, sedici anni dopo, con un capitale nominale non molto superiore, ma nel frattempo l’inflazione galoppante ne aveva eroso pesantemente il potere d’acquisto. Tra il 1966 e il 1982, infatti, l’indice Dow Jones (aggiustato per l’inflazione) perse circa il 73% del suo valore reale. In pratica, pur non azzerandosi mai in termini nominali, il mercato azionario distrusse ricchezza reale: i prezzi stagnanti uniti a un’inflazione che raggiunse picchi vicini al 15% annuo significarono perdite consistenti per gli investitori in termini di capacità d’acquisto.
Per contestualizzare meglio, la tabella seguente confronta i rendimenti medi annui del mercato azionario statunitense (indice S&P 500, includendo i dividendi) nei vari decenni, insieme all’inflazione media annua registrata e al rendimento reale medio (cioè al netto dell’inflazione) di ciascun periodo:
| Decennio | Rendimento annuo medio (nominale S&P 500) | Inflazione media annua (CPI USA) | Rendimento annuo medio reale |
|---|---|---|---|
| 1960-1969 | ~7,8% | ~2,5% | ~5% |
| 1970-1979 | ~5,9% | ~7,4% | -1,5% (negativo) |
| 1980-1989 | ~17,3% | ~5,1% | ~12% |
| 1990-1999 | ~18,2% | ~3% | ~15% |
| 2000-2009 | ~-0,9% (leggermente negativo) | ~2% | ~-3% (negativo) |
| 2010-2019 | ~13,4% | ~2% | ~11% |
Fonte dati: elaborazione dell’autore su indici S&P 500 (total return) e dati inflazione US CPI.
Come si nota, il decennio degli anni ’70 fu l’unico, insieme ai 2000, a presentare un rendimento reale medio negativo per le azioni. Negli anni ’70, nonostante un modesto +5-6% annuo in termini nominali, l’inflazione mediamente superiore al 7% annuo portò a una perdita reale di circa l’1-2% all’anno in media. Per contro, negli anni ’80 e ’90 il mercato azionario fu molto generoso (oltre +15% reale medio annuo), mentre anche negli anni 2010 il rendimento reale è stato elevato (~11% annuo), favorito da inflazione bassa e forte crescita dei profitti aziendali. Gli anni 2000 hanno visto anch’essi un risultato deludente (-3% reale medio), a causa di due crisi ravvicinate (scoppio della bolla internet nel 2000-2002 e crisi finanziaria nel 2008).
Negli anni Settanta, a pesare sui mercati furono una combinazione di fattori macroeconomici e psicologici. L’economia visse un periodo di stagflazione, un mix tossico di inflazione elevata e stagnazione della crescita. Gli shock petroliferi del 1973 e 1979 fecero schizzare in alto i prezzi dell’energia, alimentando la spirale inflazionistica. La disoccupazione rimase alta in molti Paesi occidentali mentre la crescita economica era debole, un contesto che erodeva i margini delle imprese. La politica monetaria inizialmente fu incerta: le banche centrali (in particolare la Fed negli USA) furono accusate di essere “dietro la curva” nel combattere l’inflazione, mantenendo i tassi di interesse troppo bassi all’inizio del decennio e poi dovendo rincorrere l’aumento dei prezzi con strette monetarie tardive ma molto aggressive alla fine del periodo (il celebre shock Volcker del 1979-81, con i tassi Fed oltre il 15%). Tutto ciò creò forti turbolenze finanziarie: si verificarono ripetuti ribassi del mercato (oltre quattro importanti correzioni o bear market tra il 1966 e il 1982, con crolli del 20-40% intervallati da rimbalzi effimeri).
Dal punto di vista degli investitori, gli anni ’70 furono estenuanti perché caratterizzati da molte “false partenze”: più volte la Borsa diede l’illusione di riprendersi, per poi tornare a scendere. Ogni rally veniva vanificato dall’ennesimo aumento dell’inflazione o da una recessione in arrivo, instillando sfiducia duratura. Il risultato fu che chi aveva puntato sulle azioni nel decennio precedente vide pochissimi frutti, specialmente in termini reali. Anche considerando i dividendi (che negli anni ’70 erano relativamente alti, con dividend yield medi del 4-5%), questi riuscirono solo in parte a compensare l’inflazione galoppante. Non sorprende che un’intera generazione di investitori sia rimasta scottata da quell’esperienza, sviluppando un’avversione di lungo termine verso l’azionario.
Paralleli tra oggi e gli anni ’70: perché il passato fa paura
Visti i precedenti, non è difficile capire perché alcuni osservatori temano che gli anni 2020 possano somigliare ai ’70. Ecco i principali paralleli e analogie che vengono citati:
- Fiammata inflazionistica: dopo un lungo periodo di inflazione bassa e stabile, negli anni 2021-2022 l’inflazione è risalita rapidamente ai livelli più alti dagli anni ’80, sia negli Stati Uniti che in Europa. Le cause sono diverse (politiche monetarie espansive prolungate, stimoli fiscali, shock alle catene di approvvigionamento post-Covid, rincari energetici anche per via della guerra in Ucraina), ma il risultato è stato un brusco cambio di regime. Questo ricorda gli anni ’70, quando l’inflazione uscì dal controllo. La paura è che, come allora, domare definitivamente l’inflazione risulti difficile, costringendo a condizioni finanziarie restrittive per molti anni.
- Stretta monetaria aggressiva: per far fronte all’aumento dei prezzi, la Fed ha alzato i tassi d’interesse in modo rapido e consistente a partire dal 2022, portandoli dai valori prossimi allo zero (dell’era pandemica) fino a oltre il 5% nel giro di poco più di un anno. Anche altre banche centrali hanno seguito. Questo ricorda, in parte, la stretta di Volcker (anche se oggi i tassi reali sono ancora inferiori a quelli di allora). L’incertezza ora riguarda la durata e l’entità di questa stretta: i mercati non sanno se la Fed continuerà ad alzare i tassi, se li manterrà elevati a lungo o se sarà costretta a tagliarli in caso di recessione. Gli anni ’70 furono caratterizzati da politiche monetarie ondivaghe (stop-and-go), con tagli prematuri seguiti da nuove fiammate inflazionistiche. Il timore è di ricascare in un circolo vizioso simile: se la Fed allenta la guardia troppo presto, l’inflazione potrebbe riaccendersi; se invece resta troppo restrittiva, potrebbe aggravare il rallentamento economico. Questa incertezza sulla Fed contribuisce alla volatilità e al sentiment negativo, proprio come avveniva negli anni ’70 quando ogni mossa della banca centrale poteva innescare euforia o panico sui mercati.
- Valutazioni iniziali elevate: come discusso, oggi i mercati azionari partono da multipli alti. Anche alla fine degli anni ’60, prima dell’inizio della stagnazione settantiana, le Borse avevano conosciuto un lungo bull market (gli anni ’50 e buona parte dei ’60) che aveva gonfiato le valutazioni. Emblematico negli USA fu il fenomeno delle “Nifty Fifty”, un gruppo di 50 titoli azionari di alta qualità e crescita che nei primi anni ’70 venivano considerati quasi “invincibili” e comprati a qualsiasi prezzo, salvo poi crollare anch’essi durante la crisi del 1973-74. Alcuni intravedono un parallelo con l’elevata concentrazione odierna degli indici: nell’S&P 500 una manciata di grandi titoli tech (Apple, Microsoft, Google, Amazon, Nvidia e pochi altri) pesa una quota elevatissima della capitalizzazione totale. Questo significa che l’andamento del mercato nel suo complesso è trainato da pochi nomi; un loro eventuale indebolimento potrebbe trascinare giù l’intero indice, esattamente come accadde quando le “Nifty Fifty” persero il loro smalto.
- Shock geopolitici e materie prime: gli anni ’70 furono scossi dalle crisi petrolifere legate ai conflitti in Medio Oriente (guerra del Kippur nel 1973, rivoluzione iraniana nel 1979). Oggi, sebbene l’economia sia meno dipendente dal petrolio in proporzione al PIL rispetto ad allora, restiamo vulnerabili a shock di approvvigionamento energetico e a tensioni geopolitiche. La guerra tra Russia e Ucraina nel 2022 ha avuto effetti simili ad uno shock petrolifero in Europa, facendo impennare i prezzi di gas e elettricità. Più in generale, il clima internazionale è teso (rivalità USA-Cina, conflitti regionali) e il processo di globalizzazione sembra rallentare o frammentarsi. Questo contesto di incertezza globale ricorda sotto alcuni aspetti gli anni ’70 (guerre fredde, crisi internazionali) e può incidere negativamente sulla fiducia delle imprese e degli investitori.
In sintesi, alcuni ingredienti della “ricetta” anni ’70 sono presenti: inflazione non ancora del tutto sotto controllo, politica monetaria restrittiva e imprevedibile, valutazioni azionarie alte ereditate da un lungo bull market precedente, possibili shock esterni sfavorevoli. Non stupisce dunque che serpeggi una certa preoccupazione: gli investitori più pessimisti vedono all’orizzonte la possibilità di una fase prolungata di rendimenti azionari bassi, se non addirittura negativi in termini reali – in altre parole, un ritorno di “rendimenti in stile anni ’70”.
Differenze chiave: perché la storia potrebbe non ripetersi uguale
Nonostante le somiglianze elencate, è importante sottolineare che oggi il contesto economico-finanziario presenta anche profonde differenze rispetto agli anni Settanta. Queste differenze potrebbero evitare che la storia si ripeta nello stesso modo, offrendo invece ai mercati la possibilità di ottenere risultati migliori. Ecco alcuni fattori distintivi dei nostri giorni:
- Banche centrali più credibili e decise: La lezione degli anni ’70 non è andata persa. Oggi le banche centrali, a partire dalla Fed, hanno ben presente l’importanza di ancorare le aspettative di inflazione e intervenire con tempestività. Se negli anni ’70 inizialmente si esitò ad alzare i tassi per non deprimere l’economia (finendo però per aggravare l’inflazione), stavolta la Fed ha mostrato maggiore prontezza nell’inasprire la politica monetaria appena l’inflazione si è rivelata persistente. Certo, resta il rischio di errori di calibrazione, ma in generale la cultura della stabilità dei prezzi è più radicata oggi. Inoltre, esistono strumenti macroprudenziali e canali di comunicazione (forward guidance) di cui la Fed non disponeva 50 anni fa, il che permette una gestione potenzialmente più fine dell’economia. Questo potrebbe significare riuscire a domare l’inflazione senza dover spingere l’economia in una recessione profonda come fu invece necessario nel 1980-82. Se l’inflazione viene riportata verso il 2-3% nel giro di alcuni anni, il confronto con gli anni ’70 terminerebbe qui: quella stagflazione fu così deleteria proprio perché l’inflazione rimase alta per oltre un decennio. Oggi non è affatto scontato che accada lo stesso.
- Mercati del lavoro e struttura economica differenti: Negli anni ’70 la dinamica salariale era esplosiva, alimentata da una popolazione giovane, sindacati forti e meccanismi di adeguamento automatico dei salari al costo della vita. Oggi molte economie avanzate hanno popolazioni più anziane (quindi meno pressione dal lato della domanda di beni) e un mercato del lavoro più flessibile. La crescita dei salari, pur in rialzo, è finora rimasta più contenuta rispetto all’inflazione, evitando di innescare quella spirale prezzi-salari che fu centrale negli anni ’70. Inoltre, alcuni fattori strutturali – ad esempio la digitalizzazione e la globalizzazione – hanno effetti disinflazionistici (rendono la formazione dei prezzi più efficiente e la concorrenza globale limita il potere di prezzo delle imprese). È vero che la globalizzazione sta rallentando, ma il livello di integrazione mondiale delle economie è comunque molto più elevato che nel 1975. Questo tende a smorzare gli eccessi: ad esempio, oggi shock locali di offerta (come un problema di produzione in un Paese) possono essere compensati più facilmente importando da altri, limitando le carenze e le impennate di prezzo che erano invece devastanti 50 anni fa.
- Situazione finanziaria di famiglie e aziende: Negli anni ’70 molti investitori individuali subirono pesanti perdite reali perché tenevano una buona parte del patrimonio in attività monetarie o obbligazioni a tasso fisso, che vennero erose dall’inflazione. Oggi sia le famiglie sia soprattutto le imprese hanno imparato a gestire meglio questi rischi: l’utilizzo di strumenti finanziari indicizzati all’inflazione è più diffuso, e in generale c’è maggiore consapevolezza dei pericoli dell’inflazione sul risparmio. Le aziende, dal canto loro, hanno bilanci più solidi (in media) e molti debiti a tasso fisso già contratti a condizioni vantaggiose durante gli anni di tassi zero, il che le rende più resilienti a un periodo di tassi in rialzo rispetto alle aziende degli anni ’70. Inoltre, i mercati finanziari sono molto più profondi e diversificati oggi: gli investitori istituzionali (fondi pensione, assicurazioni, fondi sovrani) hanno enormi masse da allocare e tendenzialmente comprano ai ribassi di mercato se intravedono valore. Questo “fondo compratore” può mitigare i crolli prolungati. Negli anni ’70, la finanza era meno sviluppata e la partecipazione al mercato azionario era più ristretta, il che amplificò la volatilità al ribasso.
Ma soprattutto, un elemento potrebbe fare la differenza tra un futuro di stagnazione e uno di rinnovata crescita: l’innovazione tecnologica. Su questo punto vale la pena approfondire, perché è qui che molti vedono la svolta positiva capace di scongiurare un nuovo decennio perduto.
Il ruolo dirompente dell’intelligenza artificiale e dell’innovazione tecnologica
A cambiare radicalmente le carte in tavola rispetto agli anni ’70 è la presenza, oggi, di potenti forze tecnologiche dirompenti, prima fra tutte l’intelligenza artificiale (AI). Gli anni Settanta furono un periodo relativamente povero di progresso tecnologico visibile nel quotidiano (a parte i primi calcolatori e il settore aerospaziale): non vi furono innovazioni paragonabili, per diffusione di massa, all’avvento di Internet o degli smartphone dei decenni successivi. Oggi, invece, ci troviamo in un’epoca di rapida evoluzione tecnologica. L’AI in particolare viene spesso paragonata a una “nuova elettricità” o a un cambiamento di paradigma industriale. Come può l’AI influire sui mercati azionari e sull’economia?
In primo luogo, l’AI ha il potenziale per aumentare la produttività in quasi tutti i settori. Automazione avanzata, algoritmi di machine learning, robotica e analisi dei big data possono rendere le aziende più efficienti, ridurre costi operativi e aprire la strada a nuovi prodotti e servizi. Se questo aumento di produttività si concretizzerà, l’economia potrebbe crescere a ritmi più sostenuti senza generare troppa inflazione (perché l’offerta di beni e servizi cresce insieme alla domanda). Alcune stime sono impressionanti: secondo Goldman Sachs, l’adozione diffusa dell’AI potrebbe addirittura far aumentare il livello del PIL globale di un 15% oltre il trend nel prossimo decennio. Anche previsioni più prudenti indicano comunque un contributo positivo significativo. In pratica, l’AI potrebbe aggiungere punti percentuali di crescita all’anno rispetto allo scenario in cui questa rivoluzione tecnologica non avvenisse.
Maggior crescita economica significa, a tendere, maggiori utili per le aziende. Dunque anche se i multipli di valutazione dovessero contrarsi (come spesso accade dopo i picchi), gli utili “E” nel rapporto P/E potrebbero aumentare grazie all’AI, sostenendo così i prezzi azionari su un trend di crescita. In altre parole, l’AI potrebbe contribuire a evitare una stagnazione secolare degli utili e quindi dei mercati, rendendo i rendimenti azionari migliori di quanto furono negli anni ’70. Allora infatti la produttività era stagnante, mentre oggi abbiamo la concreta speranza di un nuovo boom di produttività simile a quello avvenuto con l’avvento dei computer e di Internet (boom che, ricordiamo, portò agli ottimi rendimenti azionari degli anni ’80 e ’90).
Va detto che gli effetti delle grandi innovazioni non sono immediati. La storia insegna che serve tempo perché le tecnologie dirompenti si traducano in guadagni di produttività misurabili a livello macro. Ad esempio, l’uso capillare dei personal computer e di Internet iniziò negli anni ’80, ma fu solo dalla metà degli anni ’90 che negli Stati Uniti si registrò un chiaro aumento del tasso di produttività, proseguito poi fino ai primi anni 2000. Con l’AI potremmo vivere un percorso analogo, anche se molti ritengono che potrebbe essere più rapido grazie all’accumulo di conoscenze e all’adozione immediata su scala globale. Alcuni analisti stimano che gli effetti tangibili dell’AI sull’economia inizieranno a vedersi già verso la fine di questo decennio (anni 2028-2030), molto prima di quanto impiegarono innovazioni passate a fare la differenza. Questo significa che nel medio termine l’AI potrebbe aiutare ad attenuare eventuali elementi di stagflazione residui, aprendo una nuova fase di espansione economica negli anni 2030.
Oltre all’AI, ci sono altre innovazioni e trend dirompenti che differenziano il nostro tempo dagli anni ’70 e che potrebbero sostenere i mercati: la transizione energetica verso fonti rinnovabili e tecnologie “clean” sta catalizzando investimenti enormi e creando nuovi settori industriali; la digitalizzazione avanzata (cloud computing, IoT, 5G) continua a espandere margini di efficienza; progressi in biotecnologia e medicina promettono di aprire mercati completamente nuovi (si pensi alla frontiera delle terapie geniche, o alle applicazioni dell’mRNA sviluppate durante la pandemia). Tutti questi elementi costituiscono motori di crescita che negli anni ’70 non esistevano affatto. Se anche solo alcuni di essi manterranno le promesse, potrebbero contribuire a rendere i prossimi 10-20 anni molto diversi dal “decennio perduto” che fu il 1973-1982. Invece di stagnazione, potremmo assistere a cambiamenti strutturali positivi, con interi nuovi comparti che emergono in Borsa e trainano gli indici verso l’alto.
Da notare che la stessa natura del mercato azionario oggi è più orientata verso società tecnologiche e di servizi rispetto agli anni ’70. Allora gli indici erano dominati da aziende manifatturiere, petrolifere, automobilistiche – settori che soffrirono molto la stagflazione. Oggi i listini vedono una prevalenza di aziende tech e comunicazioni, che in teoria dovrebbero essere più resilienti all’inflazione (hanno meno costi materie prime) e beneficiare maggiormente dei progressi tecnologici. Naturalmente, questo non le rende immuni da crisi (le dot-com crollarono nel 2000), ma il punto è che la composizione settoriale del mercato è cambiata in modo da poter sfruttare meglio eventuali spinte innovative. Se negli anni ’70 investire in “nuove tecnologie” era difficile (bisognava magari puntare su startup o piccole società non ancora in Borsa), oggi molte delle aziende leader dell’AI e della digitalizzazione sono già colossi quotati: ciò significa che un investitore sull’S&P 500 partecipa direttamente alla rivoluzione tech in corso. In un certo senso, il mercato incorpora la scommessa sull’innovazione, mentre negli anni ’70 il mercato “subiva” e basta il declino dei settori tradizionali senza catalizzatori positivi di pari scala.
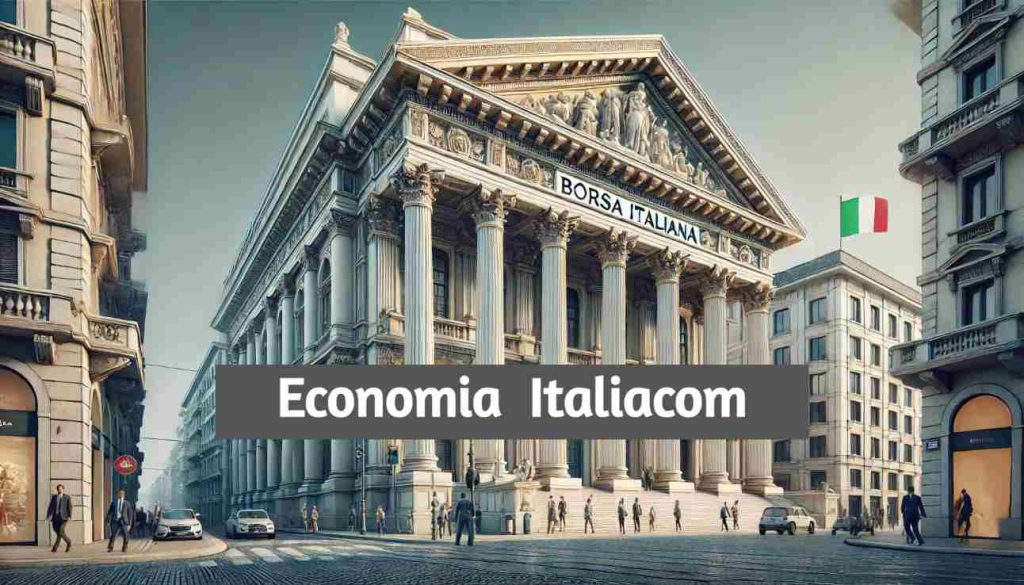
Prospettive future: realismo e prudenza, ma anche opportunità
Tutti questi elementi suggeriscono che, pur dovendo mantenere un sano realismo, le prospettive dei mercati azionari oggi non sono condannate a replicare per forza lo schema degli anni ’70. Certo, dopo un periodo di rendimenti eccezionali come quello scorso (anni 2010 fino al 2021), è ragionevole aspettarsi rendimenti più moderati nei prossimi anni. I tassi di interesse più alti e la fine di alcune politiche ultra-espansive (quantitative easing) hanno già aumentato il costo del capitale e pesato sulle valutazioni, portando a correzioni nel 2022. Ma moderato non significa necessariamente negativo in termini reali.
Gli scenari previsionali degli analisti in realtà sono piuttosto divergenti. Abbiamo visto quelli pessimistici (rendimenti quasi zero per una decade, secondo alcune banche d’affari). Dall’altro lato ci sono anche scenari più ottimistici: ad esempio, secondo i modelli di J.P. Morgan AM, il mercato USA potrebbe ancora generare circa un 7-8% annuo nei prossimi 10-15 anni, un valore non lontano dalla media storica, grazie soprattutto al contributo di innovazione e crescita economica sostenuta. La verità probabilmente sta nel mezzo, ed è importante ricordare che predire esattamente i rendimenti decennali è arduo – troppe variabili possono intervenire (cicli economici, eventi imprevisti, scelte politiche).
Per gli investitori privati e i piccoli risparmiatori, qual è allora l’atteggiamento giusto in questa fase? Prudenza ma non panico. Prudenza nel calibrare le aspettative: dopo anni di guadagni facili, prepariamoci a possibili volatilità e a rendimenti meno lineari. È saggio diversificare le proprie allocazioni, non fare eccessivi affidamenti su un solo mercato o settore, e magari mantenere un orizzonte temporale più lungo per compensare eventuali fasi di magra. Allo stesso tempo, non bisogna farsi paralizzare dalla paura di un nuovo 1970: la situazione odierna presenta anche opportunità che allora non c’erano. Investire nell’innovazione (pur con criterio) può dare soddisfazioni proprio in contesti di svolta tecnologica. Inoltre, se l’inflazione dovesse scendere e stabilizzarsi, i mercati potrebbero ritrovare condizioni favorevoli: storicamente, le azioni tendono a performare bene in ambienti di inflazione bassa/stabile e crescita economica discreta – uno scenario che, con un po’ di fortuna e buona gestione delle politiche, potremmo ritrovare entro qualche anno.
In conclusione, i mercati azionari affrontano certamente sfide e incognite non banali in questi anni 2020. Le prospettive a breve termine possono essere nebulose: un mix di possibili rallentamenti economici, aggiustamenti valutativi e strascichi dell’alta inflazione potrebbe limitare i guadagni e tenere gli investitori sulle spine. Tuttavia, le lezioni del passato e le forze del presente suggeriscono che un replay esatto degli anni ’70 non è scritto nel destino. La storia economica raramente si ripete in fotocopia; spesso “fa rima”, ma cambiano gli attori e gli elementi di contesto. Oggi quei nuovi attori sono l’AI e le tecnologie disruptive, coadiuvate da banche centrali più consapevoli e da economie globali interconnesse. Il risultato finale potrebbe essere un decennio di rendimenti più bassi rispetto all’ultimo, ma comunque positivi e ben lontani dalla catastrofe temuta. In altre parole, i rendimenti in stile anni ’70 potrebbero tornare alla ribalta in termini di direzione (in rallentamento rispetto al passato), ma non necessariamente in termini di gravità (una stagnazione reale prolungata).
Come sempre, solo il tempo dirà quale scenario si materializzerà. Nel frattempo, agli investitori conviene restare informati, mantenere la disciplina e magari trovare un equilibrio tra la memoria storica (che invita a cautela quando il mercato è caro e l’inflazione sale) e la fiducia nel futuro (tenendo conto del potenziale di trasformazione positiva che il progresso porta con sé). I mercati azionari, dopotutto, hanno dimostrato nel lungo periodo una straordinaria capacità di adattamento e crescita attraverso guerre, crisi e rivoluzioni industriali. Scommettere contro la creatività umana e l’innovazione si è rivelato raramente vincente. Anche stavolta, quindi, pur navigando a vista tra possibili scogli, vale la pena tenere un occhio fisso all’orizzonte delle opportunità che potrebbero delinearsi.
Fonti
- Ritholtz, Barry. “3%: Great Depression, GFC, 1970s & 2020s?” – Analisi delle previsioni di Goldman Sachs sui rendimenti azionari del prossimo decennio, con riferimento ai paralleli storici (The Big Picture, 24 Ottobre 2024).
- Discovery Alert. “The 1970s Stock Market Crash: A 16-Year Wealth Destroyer” – Articolo che descrive l’andamento del mercato azionario negli anni 1966-1982, evidenziando la perdita del 73% in termini reali e l’impatto dell’inflazione (23 Luglio 2025).
- Research Affiliates. “CAPE Fear: Why CAPE Naysayers Are Wrong” – Pubblicazione di Rob Arnott et al. che riporta come il CAPE ratio del mercato USA abbia toccato livelli storicamente elevati (paragonabili solo al 1929 e 2000) e discute le implicazioni per i rendimenti futuri (Gennaio 2018).
- J.P. Morgan Private Bank. “How AI can boost productivity and jump start growth” – Approfondimento sulle potenzialità dell’intelligenza artificiale nell’accrescere la produttività e il PIL, citando una stima di Goldman Sachs su un +15% cumulativo al PIL in 10 anni grazie all’AI (dato al 2024).
Articoli simili:
Previsioni investimenti per il 2025
Apri il tuo Conto Trading Fineco
Accedi a piattaforme professionali, analisi in tempo reale e oltre 20.000 strumenti finanziari da un’unica interfaccia. Zero costi di apertura, massima affidabilità.
Pubblicità di affiliazione – Economia Italiacom può ricevere una commissione se apri un conto tramite questo link, senza alcun costo per te. Investire comporta rischi: informati bene prima di operare.

